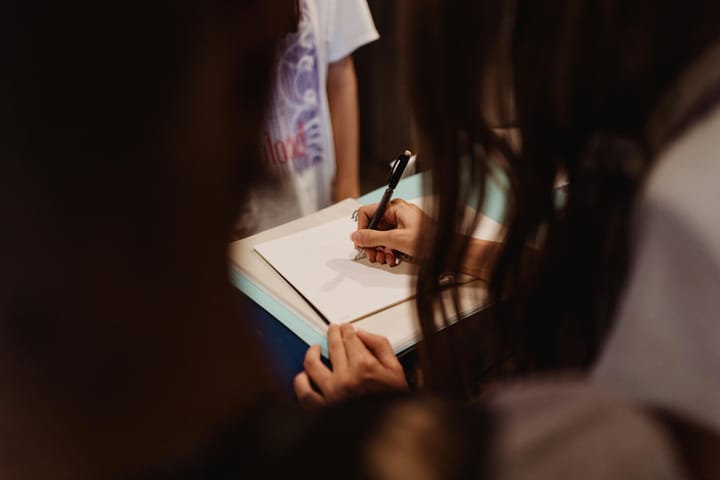La Torino che non si muove: viaggio nelle aree dimenticate

L’Unica Torino fa parte di un nuovo progetto di newsletter locali, che parte da quattro province del Piemonte. Per dubbi, domande, suggerimenti puoi scriverci a info@lunica.email. Se vuoi saperne di più qui trovi la pagina principale.
“Torino always on the move”, Torino sempre in movimento. Sono passati più di vent’anni da quando l’espressione coniata per le Olimpiadi 2006 compariva prepotentemente su palizzate e transenne usate per delimitare i tantissimi cantieri che caratterizzavano la Torino pre-olimpica. Oggi quel tempo appare lontano, ma il tema del dinamismo non ha smesso di affascinare amministratori e comunicatori cittadini, tant’è che “Il piano va veloce” è il motto che contraddistingue i lavori in città finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Slogan a parte, certe trasformazioni stanno in effetti procedendo spedite (basti pensare, ad esempio, ai lavori di riqualificazione del Valentino che includono anche la nuova biblioteca civica nei vecchi spazi di Torino Esposizioni), ma diverse aree della città sono ancora in cerca di una destinazione, sospese tra problemi burocratici, progetti mai avviati che oggi appaiono anacronistici o semplicemente troppo grandi (e costosi) da riqualificare.
Perché in queste aree il futuro si è fermato? Secondo Matteo Robiglio, urbanista e docente al Politecnico di Torino, i motivi sono diversi: «La spinta propulsiva alla rigenerazione ha avuto una prima battuta d’arresto con la crisi economica globale negli anni 2008-11», spiega a L’Unica. «Poi, alcuni progetti sono ripartiti, mentre altri sono rimasti al palo. I motivi? Sono porzioni grandi che richiedono notevoli investimenti, sono cambiati trend demografici ed esigenze della città e questo ha messo in crisi il modello di rigenerazione basato sullo sviluppo di aree residenziali attorno a un centro commerciale».
Il Palazzo del Lavoro
Così molte aree di Torino sono finite fuori dai radar, anche se non fuori dalla vista. Il caso più noto ed evidente è il Palazzo del Lavoro, che, con la sua mole brunita di ruggine, da ormai un ventennio accoglie – si fa per dire – chi arriva a Torino da Sud. Dopo una serie di progetti rimasti sempre solo su carta (anche qui si era ipotizzato l’onnipresente supermercato), nelle scorse settimane sono emerse alcune indiscrezioni secondo cui l’immobile, progettato per “Italia61” da Pierluigi Nervi, interesserebbe al fondo sovrano del Qatar, guidato dalla sorella dell’emiro, Al Mayassa bint Al-Thani, appassionata d’arte e mecenate, che proprio a Palazzo del Lavoro vorrebbe realizzare un nuovo centro dedicato all’arte con un investimento di circa 500 milioni di euro. Ad oggi, però, le indiscrezioni non si sono trasformate in passaggi formali, per cui è ancora presto per sciogliere le riserve sul futuro di quello che negli anni è diventato un “ecomostro”.
L’ex Materferro
Spostando lo sguardo verso il centro della città, l’area ex Materferro è un triangolo di circa dieci ettari di superficie incuneato tra i quartieri Crocetta, Santa Rita e San Paolo. Fino alla fine del secolo scorso, vi operavano le officine Materferro, un grande stabilimento metalmeccanico specializzato in componenti ferroviari (vagoni e binari). Dopo la chiusura della fabbrica, la zona è stata coinvolta in vari progetti di riconversione. Qui avrebbe inizialmente dovuto sorgere il grattacielo della Regione Piemonte, poi costruito in zona Lingotto. Nonostante sia circondata da complessi di edifici recenti, l’area è sempre rimasta inutilizzata. Dal 2008 è proprietà di RUI Spa, un’azienda che faceva capo a Franco Costruzioni, l’impero del mattone dichiarato fallito nel 2024. Proprio in quell’anno, il Comune ha avviato un confronto con la proprietà per definire il futuro dell’area, ma al momento non sono noti sviluppi concreti.
Siamo sulla cosiddetta “Spina Centrale”, la porzione di Torino sopra il passante ferroviario riqualificata a partire dagli anni Novanta. Secondo Robiglio, questo progetto è rappresentativo di quanto di buono è stato fatto nei decenni passati: «La Spina è figlia del Piano regolatore e della determinazione nel metterlo in pratica, ma anche della disponibilità a plasmarlo in corso d’opera con una certa elasticità. Oggi le persone quasi non credono che un tempo il viale della Spina fosse una trincea ferroviaria e nessuno rimpiange il parco che in origine avrebbe dovuto sorgere al posto delle OGR (gli spazi delle ex Officine Grandi Riparazioni ferroviarie diventate uno spazio per eventi, ndr). Decidere di conservarle e farne il luogo straordinario che sono oggi fu una scelta che dimostrò la capacità di cogliere il mutamento della sensibilità e delle esigenze».
Il Lotto Torre
Se uno dei grattaceli previsti dal Piano regolatore generale sulla “Spina” ha visto la luce (il Grattacielo Intesa Sanpaolo), quello che avrebbe dovuto essere il suo dirimpettaio non è sorto, almeno per ora, creando un vuoto in pieno centro, delimitato da muri e palizzate che conferiscono un certo senso di precarietà. È il cosiddetto “Lotto Torre”, un’area di 7.370 metri quadrati, dove un tempo sorgevano strutture accessorie alla vecchia stazione di Porta Susa, che prende il nome dalla torre per uffici che avrebbe dovuto sorgervi.
Per quanto già dal 2018 FS Sanpaolo Sistemi Urbani, proprietaria del terreno, e Comune di Torino abbiano formalizzato i diritti edificatori, nessun progetto concreto è stato finora avviato, in parte a causa delle elevate pretese economiche di FS per la cessione. Tuttavia nel 2024, la società Newcleo, attiva nel settore dell’energia nucleare innovativa, ha annunciato l’intenzione di costruire la sua sede italiana proprio nel Lotto Torre, come tassello centrale del progetto “Torino innovation mile”, che punta a collegare il Politecnico alla stazione Dora trasformando Porta Susa in un nodo centrale della nuova economia della conoscenza. Al momento sono in corso trattative tra le parti, senza accordi definitivi.
Se questa newsletter ti è stata inoltrata, puoi iscriverti cliccando qui:
L’ex Westinghouse
A poche centinaia di metri di distanza, nel quartiere Cenisia, l’area ex Westinghouse (70 mila metri quadrati complessivi) è in qualche modo emblematica delle difficoltà e lentezze della rigenerazione urbana torinese. Un tempo occupata dalle Officine Westinghouse, specializzate nella produzione di materiale elettrico ferroviario, a partire dagli anni Ottanta è caduta in disuso. Nei decenni, alcuni capannoni sono stati abbattuti: ne resta in piedi uno lungo via Borsellino, mentre altre parti sono state temporaneamente riconvertite in parcheggi e in un piccolo giardino autogestito dai cittadini (parco Artiglieri da Montagna). A inizio anni Duemila, su quel terreno avrebbe dovuto sorgere un grande polo culturale pubblico, comprensivo di biblioteca e teatro. Tramontata quell’ipotesi, nel 2014 è stato presentato un nuovo progetto da parte della catena di supermercati Esselunga, nel frattempo divenuta proprietaria dei terreni.
Il progetto prevede un centro congressi da 5.000 posti, un supermercato Esselunga e un albergo da circa 180 camere. Tuttavia, negli ultimi dieci anni la situazione è rimasta congelata a causa delle mutate condizioni economiche, di un ricorso presentato da Coop (rigettato nel 2023) e della contrarietà di alcuni gruppi di cittadini, preoccupati per la perdita di verde pubblico. Ad oggi, l’iter autorizzativo non è stato ancora completato. Le ipotesi più ottimistiche prevedono l’apertura dei cantieri nel 2025 per la durata di almeno tre anni.
Thyssen, il deserto dopo la tragedia
Secondo Matteo Robiglio, tra gli interventi di rigenerazione meglio riusciti degli scorsi decenni c’è il recupero delle tettoie ex Teksid, in zona Parco Dora: «Anche in quel caso si è trattato di un intervento in origine non previsto nel Piano regolatore. È frutto di un concorso internazionale di progettazione, che ha consegnato a Torino un enorme spazio coperto, sempre aperto, che ospita una pluralità di eventi, dal “Kappa Future Festival” ai festeggiamenti per la fine del Ramadan, mentre tutti i giorni i ragazzi giocano a basket o corrono sugli skate: siamo agli estremi del pluralismo urbano».
La città non ha certo esaurito gli spazi ex industriali da riqualificare. Anzi, alcune delle sfide del futuro si giocano proprio là dove un tempo c’erano le fabbriche e il lavoro. Tra queste, l’ex acciaieria ThyssenKrupp, lungo corso Regina Margherita, è una ferita aperta. Prima di tutto per il tragico incidente che, il 6 dicembre 2007, è costato la vita a sette operai. Poi perché da allora l’enorme area di circa 300 mila metri quadrati è rimasta sospesa in un’immobilità della quale per ora non si intravede la fine. Il sito infatti è una specie di deserto industriale. Oggi la proprietà fa capo al gruppo Acciai Speciali Terni/Arvedi, molti dei capannoni sono stati abbattuti ma il suolo è altamente inquinato: nelle falde e nei terreni sono state riscontrate concentrazioni di sostanze contaminanti, fra cui cromo esavalente, idrocarburi e metalli pesanti derivanti dalle lavorazioni siderurgiche.
Dopo anni di immobilismo, a dicembre 2023 il Comune ha approvato un piano di bonifica e messa in sicurezza finanziato con 4,5 milioni di euro, dando il via a interventi attesi da anni: nell’arco di circa sei anni verranno trattate le porzioni di terreno contaminate, riducendo il cromo nel suolo, impermeabilizzando zone critiche per evitare dispersioni e rimuovendo gli idrocarburi presenti. Solo dopo sarà possibile immaginare un futuro per questi trenta ettari di città. Per ora nulla è definito: c’è chi immagina un polmone verde o un parco della memoria, in ricordo delle vittime del 2007, e chi propone di destinare almeno una parte a nuove attività produttive (ad esempio, nell’ambito della data economy, visti i progetti di insediamento di data center cittadini). Di certo la ThyssenKrupp resterà ancora per molti anni un buco nero nel cuore di Torino.

Le vecchie Ferriere
Alle spalle dell’ex acciaieria c’è un altro vasto spazio ex industriale ancora in cerca di una funzione: l’area degli ex stabilimenti Teksid – Officine Ferriere. Si tratta di un comprensorio industriale storico (50 mila metri quadrati) legato al gruppo FIAT, un tempo dedicato alla fonderia e alle lavorazioni metallurgiche pesanti. Le attività sono cessate nei primi anni Duemila, lasciando capannoni in rovina poi parzialmente abbattuti. Per anni, niente si è mosso se non sporadici sgomberi di insediamenti abusivi.
Il quartiere Lucento guardava con speranza a un progetto annunciato nel 2018: la realizzazione su quest’area di studentati universitari per il Politecnico e l’università, con demolizione dei vecchi stabilimenti e costruzione di residenze per studenti. Ora quel piano è naufragato, principalmente a causa degli enormi costi legati alla bonifica dei terreni dagli agenti chimici che hanno anche inquinato la falda acquifera, ma è notizia di questi ultimi mesi un cambio di strategia che porterebbe nelle ex fabbriche enormi data center che potrebbero fare di Torino uno snodo importante per il traffico dati. Nonostante alcune perplessità, soprattutto da parte della popolazione del quartiere, il piano sembra avviato: i lavori di bonifica e preparazione del terreno sono iniziati a fine 2024, l’obiettivo è di attivare il data center entro un paio d’anni.
Una palestra e una discoteca, poi il nulla
Chi transita lungo corso Dante e il cavalcavia che supera i binari ferroviari non può fare a meno di notare, sulla sinistra guidando verso il Po, una serie di edifici industriali dismessi. È ciò che resta degli ex stabilimenti OSI-Ghia, un grande complesso industriale dedicato alla produzione di carrozzerie attivo per buona parte del Novecento. Il sito è abbandonato dal 2008, cioè da quando sono cessate alcune attività che avevano preso piede nell’area, in particolare la palestra “Sport city” e la discoteca “Rock City”. Nel 2010 la fetta lungo via Egeo e via Agostino da Montefeltro è stata riqualificata e ospita un coworking. La parte preponderante è costituita da capannoni industriali con tetti a shed, in gran parte sfondati come le finestre. Le condizioni di degrado dell’area, in passato teatro anche di fatti di cronaca nera, hanno sempre destato preoccupazione nei residenti. Tuttavia, un grande progetto approvato nei primi anni Dieci del Duemila che prevedeva di realizzare in loco la nuova sede dello IED e un hotel torre da 18-20 piani, si è arenato per problemi economici e di volontà dei soggetti privati proprietari. Ad oggi, non ci sono all’orizzonte progetti concreti di riqualificazione.
La Manifattura Tabacchi
Per l’urbanista Robiglio le aree di Torino che nei prossimi anni saranno cruciali nel plasmare la città saranno quelle lambite dal percorso della futura linea 2 della metropolitana. «In particolare, tutta la zona attorno alla stazione ferroviaria metropolitana Rebaudengo e la vicina ex Gondrand (qui nelle settimane scorse sono partiti gli abbattimenti delle prime strutture fatiscenti, ndr). Poi l’asse di corso Regio Parco, dall’ex Scalo Vanchiglia alle Manifatture Tabacchi, dove potrà proseguire quella rigenerazione urbana a piccola grana che ha già trasformato l’area al di qua di corso Novara in una delle più interessanti della città».
Tra i due poli citati da Robiglio, quello che ha maggiori speranze di essere riqualificato in tempi relativamente brevi è l’ex Manifattura Tabacchi. Si tratta di un sito di oltre 90 mila metri quadrati, utilizzato dal 1758 fino al 1996 per la produzione di sigari e sigarette. Da decenni sostanzialmente abbandonato, nonostante il riutilizzo temporaneo di alcune aree da parte dell’università, è diventato rifugio di persone senza fissa dimora e teatro di attività poco chiare: è di pochi settimane fa lo sgombero, a lungo invocato dai residenti della zona, di alcuni cani che venivano allevati illegalmente nello stabile in condizioni igienico sanitarie critiche. Dopo anni di stallo, il distretto sembra vedere finalmente la luce. Nel 2022 è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’area, e il Ministero della Cultura, la Regione Piemonte, la Città di Torino, il Politecnico e l’Università di Torino. Il piano prevede la creazione di un campus con aule universitarie, residenze per studenti e servizi didattici, affiancato da un Polo archivistico di importanza nazionale. Nel 2023 si è concluso un concorso internazionale di progettazione, vinto da un team italo-internazionale, e sono in corso le fasi di progettazione esecutiva.
Lo Scalo Vanchiglia
Al polo opposto sull’asse di corso Regio Parco lo Scalo Vanchiglia ha una superficie di quasi 120 mila metri quadrati, tra corso Novara e via Regaldi, non lontano dal Cimitero Monumentale. Il sito è stato occupato, dal 1926 fino alla fine degli anni Ottanta, da uno snodo ferroviario merci a servizio delle industrie locali, dismesso con l’ampliamento dello scalo di Orbassano. Già nel 2015 il Comune ha approvato un Piano particolareggiato di recupero (PPR), il cosiddetto “Piano Regaldi” che, tra le altre cose, prevedeva l’insediamento nell’area di attività commerciali e terziarie, la costruzione di nuove case, la realizzazione di un parco urbano lineare lungo corso Regio Parco, il ripensamento della viabilità esistente. I lavori di abbattimento sono iniziati a maggio 2016. Nel 2022 è stato rilasciato un permesso di costruire sul primo e più vasto lotto del complesso, ma i lavori sono stati ritardati dalla complessità delle operazioni di bonifica ambientale, tuttora in corso. Una speranza per la riqualificazione dello Scalo Vanchiglia risiede nella futura Metro 2, che dovrebbe seguire il percorso della vecchia trincea ferroviaria, collegando la stazione Rebaudengo Fossata allo Scalo Vanchiglia, con l’obiettivo di creare un nuovo parco lineare di oltre due chilometri in superficie.
Al di là dei singoli interventi, secondo Robiglio la Torino che verrà dovrà prendere ancor più coscienza del suo ruolo di città universitaria e del “buon vivere”, offrendo, anche attraverso la rigenerazione urbana, soluzioni nuove (case, spazi di lavoro) a chi cerca un equilibrio tra qualità della vita, reddito e opportunità di crescita personale. «Un tema rilevante – conclude – sarà quello delle connessioni. Torino è una città piccola, ma l’area metropolitana e anche la montagna può diventare parte di una grande Torino che offrirebbe condizioni di vita straordinarie e difficilmente ripetibili».
Questa puntata di L’Unica Torino termina qui. Se ti è piaciuta, condividila! E se pensi che ci sia una storia di cui dovremmo occuparci, faccelo sapere: ci trovi a info@lunica.email.
📌 Parlano di noi! In un articolo pubblicato il 27 giugno su Prima online, una testata giornalistica che si occupa del mondo dell’informazione e della comunicazione, potete trovare il racconto del nostro progetto. Si legge qui.
Ti consigliamo anche:
🚞 La difficile vita dei pendolari cuneesi (da L’Unica Cuneo)
👨🏻🏭 I dati smentiscono Valditara sui giovani che non vogliono lavorare (da Pagella Politica)
📚 Come nasce una legge? Te lo spiega DORA, la piattaforma di videocorsi di Pagella Politica e Facta