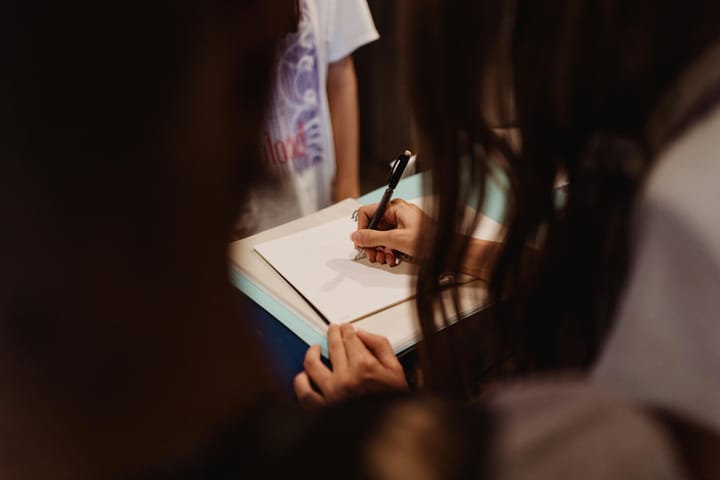Il carcere di Torino secondo l’ex garante dei detenuti

L’Unica Torino fa parte di un nuovo progetto di newsletter locali, che parte da quattro province del Piemonte.
Se vuoi saperne di più qui trovi la pagina principale.
Pensi ci sia una storia di cui ci dovremmo occuparci?
Faccelo sapere quiMonitorare in modo indipendente e tutelare le condizioni di vita di chi è recluso sono i compiti principali del garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Per dieci anni Monica Cristina Gallo ha svolto questo incarico per il Comune di Torino. Il 9 settembre ha concluso il suo secondo e ultimo mandato quinquennale. Intervistata da L’Unica, Gallo traccia un bilancio e racconta le criticità di un sistema di detenzione cittadino che fa da specchio ai problemi strutturali dei luoghi di reclusione del resto del Paese.
In questo decennio da garante, il carcere, l’istituto penale minorile e il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Torino sono stati luoghi di proteste ed eventi critici, diverse persone recluse si sono tolte la vita. Cosa è stato fatto a livello torinese? E a livello nazionale?
«Partendo dal dato più allarmante, osserviamo che negli ultimi dieci anni si sono tolte la vita 656 persone detenute negli istituti penitenziari italiani. Nella casa circondariale Lorusso e Cutugno, in particolare, si sono suicidati 17 detenuti, mentre all’interno del centro di permanenza per i rimpatri di corso Brunelleschi di Torino si registrano due morti nello stesso arco temporale, incluso quello di Moussa Baldé, suicida nel cosiddetto “ospedaletto” il 23 maggio 2021.
Sul versante regionale e locale, l’ASL ha esteso e formalizzato protocolli di intesa per la valutazione e la gestione del rischio di suicidio in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria, prevedendo screening psichiatrici all’ingresso e interventi di “primo soccorso psicologico” al manifestarsi dei segnali di crisi. Tuttavia, l’analisi qualitativa da noi condotta ha evidenziato più volte un divario fra quanto previsto nei protocolli e la prassi adottata. A livello nazionale, la circolare Renoldi [emanata l’8 agosto 2022 con il titolo “Iniziative per un intervento continuo in materia di prevenzione delle condotte suicidiarie delle persone detenute”, ndr] ha imposto linee guida uniformi per gli screening e per i piani terapeutico-riabilitativi, ma anche qui la loro applicazione risulta spesso disattesa.
Se si analizzano i dati relativi ai suicidi, emerge con evidenza che nel 2015 – anno di inizio del mio mandato – il numero dei suicidi in carcere era significativamente più basso, pari a 39 casi. In quello stesso anno, la popolazione detenuta era scesa da 68 mila a circa 52 mila unità. Questo dato conferma quanto il fenomeno suicidario sia connesso al sovraffollamento: una condizione che non solo riduce lo spazio vitale disponibile per ciascuna persona reclusa, ma compromette anche la qualità delle relazioni interpersonali e limita fortemente l’accesso a opportunità di sostegno psicologico e sociale.
Una conferma della connessione tra sovraffollamento ed eventi critici si è avuta durante la rivolta del carcere minorile Ferrante Aporti nell’estate 2024. Lì, 60 ragazzi erano rinchiusi in una struttura concepita per 42 posti, con un tasso di affollamento superiore al 120 per cento. Le tensioni accumulate per la mancanza di progetti estivi, di tempo vuoto, le notti trascorse su giacigli non adeguati è sfociata in una protesta violenta di distruzione».
Quali sono gli aspetti o gli episodi che più l’hanno colpita in questi anni? Che rapporto si è creato con le persone recluse?
«In un sistema chiuso come quello carcerario, tra tutte le incongruenze, stridenti e talvolta paradossali, che si riverberano drammaticamente sulla vita delle persone, la detenzione dei giovani relegata alle carceri destinate agli adulti è indubbiamente la situazione che più mi rammarica. Con gli anni, ho visto crescere sempre di più il numero di giovani adulti detenuti presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno.
Al cospetto della giustizia, i ragazzi devianti hanno destini diversi: chi compie un reato a 17 anni, 11 mesi e 29 giorni viene giudicato dal Tribunale per i minorenni; se condannato a una pena detentiva, la sconterà all’interno del carcere minorile, con più ampie possibilità di riabilitazione. Il giovane che compie un reato a 18 anni e un giorno verrà invece giudicato dal Tribunale ordinario e sconterà la pena in un carcere per adulti. In Italia, all’inizio del 2025, sono 5.067 i giovani detenuti under 25 nelle carceri per adulti, mentre al 30 giugno 2023 erano 3.274. Oggi si registra un incremento di quasi 1.800 unità.
L’ordinamento penitenziario italiano prevede che i giovani adulti debbano godere di trattamenti e condizioni specifiche: dovrebbero esserci sezioni separate, che rispondano alle loro esigenze particolari di sviluppo psicologico, sociale ed educativo. Nella realtà ciò non accade.
Se è vero che un organo di garanzia deve agire con distacco, è altrettanto vero che, in tale veste, ogni volta che ho colloquiato con un giovane detenuto quel distacco è venuto meno. Ogni volta che ho colloquiato con un giovane detenuto in una delle squallide stanzette messe a disposizione dall’amministrazione penitenziaria, mi sono domandata: perché tanta punizione tutta insieme? E ho riflettuto a lungo sull’inutilità di tali misure restrittive, che appaiono davvero, tristemente, finalizzate solo a sé stesse».
Nelle sue relazioni annuali dedicate a illustrare quanto osservato nel carcere Lorusso e Cutugno ha spesso documentato il degrado degli spazi e il sovraffollamento. Come è cambiata la situazione dall’inizio del suo mandato?
«Potrei risolvere il tema che lei pone affermando che la situazione, non brillante dieci anni fa, in ragione degli sporadici e limitati interventi di manutenzione nella struttura, è andata fisiologicamente peggiorando. Può però tornare utile fare un paio di esempi per cogliere gli aspetti più paradossali e drammatici di questo stato di cose. Nella gran parte delle sezioni del Lorusso e Cutugno le docce non garantiscono la costante disponibilità di acqua calda: la circostanza sarebbe già inusitata nei mesi estivi, ma, per ovvie ragioni, assume un profilo di estrema gravità in quelli invernali. Il problema è ovviamente conosciuto dai responsabili della struttura, ma finora non è stato posto in essere un intervento risolutivo capace di fornire un servizio basilare per l’igiene delle persone ristrette.
La seconda immagine è quella relativa allo spazio, spesso fatiscente, presente in ogni cella, nel quale a distanza di pochi centimetri sono presenti il wc e i fornelli a gas per la cottura dei pasti. È assai facile intuire come il degrado degli spazi porti al degrado delle condizioni di vita e attraverso di esse al degrado delle persone.
Il sovraffollamento costituisce un fattore moltiplicativo del quadro critico che ho finora presentato. Sul piano meramente quantitativo posso segnalare come nel 2015, l’istituto torinese contasse 1.162 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 1.132 posti. Sebbene il sovraffollamento fosse contenuto, il sistema penitenziario si trovava in una fase di riassetto a seguito della sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell’uomo [l’8 gennaio 2012, in seguito alla denuncia di sette detenuti nella carceri di Piacenza e Busto Arsizio, in celle con meno di 4 metri quadrati a testa a disposizione, l’Italia fu condannata per violazione all’articolo 3 della “Convenzione per i diritti umani”, che impone alle autorità di consentire a ogni detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, ndr].
L’impatto di tale pronunciamento determinò un iniziale effetto deflattivo, traducendosi in un aumento delle misure alternative alla detenzione e in un calo temporaneo delle presenze. A distanza di dieci anni, nel dicembre 2024, sono risultate presenti 1.429 persone detenute su una capienza regolamentare di 1.117 posti con un tasso di sovraffollamento del 128 per cento».
Se questa newsletter ti è stata inoltrata, puoi iscriverti cliccando qui:
Lei ha anche redatto un documento che contiene una serie di proposte alternative alla detenzione nel CPR, definendo quest’ultimo più volte come un fallimento: ci spiega perché è necessario superare questo sistema?
«Ho contribuito attivamente al percorso istituzionale volto al superamento del Centro di permanenza per il rimpatrio di corso Brunelleschi, inserendomi su una linea di continuità con il lavoro del Consiglio comunale di Torino, che a marzo 2023 ha rinnovato la richiesta di chiusura della struttura, sollecitando una riallocazione delle risorse verso politiche efficaci di integrazione cittadina. Purtroppo da alcuni mesi il CPR di Torino è nuovamente attivo e nell’anno corrente le visite sono state quattro e per ognuna è stato redatto un rapporto inviato al garante nazionale, al sindaco e all’assessore di riferimento.
Il CPR di Torino rappresenta un caso emblematico dell’inefficacia strutturale e dei costi insostenibili che caratterizzano le politiche italiane in materia di trattenimento amministrativo e rimpatrio degli stranieri. L’obiettivo dichiarato di queste strutture, ossia agevolare l’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento, si scontra con una realtà fatta di risultati marginali, alti costi pubblici e un crescente impatto umano e sociale.
I dati aggiornati al 2025 e le analisi del progetto di ricerca “Trattenuti”, realizzato da “ActionAid Italia” in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari, delineano un quadro inequivocabile: il CPR di Torino non solo non raggiunge gli obiettivi prefissati, ma si configura come un apparato burocratico e detentivo inefficace e gravoso.
Nel 2025, il CPR di corso Brunelleschi ha trattenuto 196 persone, ma soltanto 18 di queste sono state effettivamente rimpatriate. Questo dato, pari a meno del 10 per cento del totale, rivela una sproporzione significativa tra lo sforzo detentivo e i risultati ottenuti. A fronte di 18 rimpatri, 78 persone sono state rilasciate per altri motivi, di cui 10 per ragioni sanitarie. Il rilascio di un numero di persone oltre quattro volte superiore rispetto a quelle rimpatriate testimonia l’incapacità delle istituzioni preposte di raggiungere l’obiettivo fondamentale per cui è stato istituito.
L’inefficacia del CPR è ulteriormente aggravata dalla sua funzione di “propaggine del carcere”. Nel 2025, 58 persone trattenute provenivano da istituti penitenziari, in particolare dalla casa circondariale Lorusso e Cutugno. Questa cifra rappresenta circa il 30 per cento degli ingressi totali. Le persone in uscita dal circuito penale sono più difficili da espellere e rimangono detenute per periodi prolungati, spesso senza prospettive concrete di rimpatrio. In questo contesto, il trattenimento assume una dimensione afflittiva e punitiva non giustificata dal fine amministrativo che dovrebbe guidarlo.
L’aspetto economico costituisce un altro elemento centrale nella valutazione del fallimento del CPR di Torino. Il costo medio annuo della struttura tra il 2018 e il 2023 è stato di oltre 2,5 milioni di euro. La prolungata detenzione genera inoltre tensione, conflitti interni e danneggiamenti, con una conseguente impennata delle spese per manutenzione straordinaria: tra il 2018 e il 2023, il 76 per cento delle risorse per la manutenzione è stato speso per interventi straordinari. Si prevede che tali costi aumenteranno ulteriormente a seguito dell’innalzamento dei termini massimi di trattenimento a 18 mesi, introdotto nel 2023.
Accanto alle inefficienze operative ed economiche, emerge una forte criticità nella qualità dei servizi offerti. Nonostante la reintroduzione della figura dello psicologo nel 2021, il tempo medio settimanale dedicato all’assistenza psicologica è di soli 38 minuti, mentre l’informativa legale si riduce a 16 minuti settimanali per persona. Questi livelli di supporto sono insufficienti e non garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali».
Nella sua esperienza questi luoghi sono contesti dove viene rispettata la dignità dei detenuti e dove è possibile affrontare un percorso di recupero? In che modo?
«In primo luogo è opportuno precisare che ciascun contesto (casa circondariale, Istituto penale per minorenni e CPR) presenta caratteristiche peculiari, a partire dalla tipologia delle persone ristrette che la popolano. Ma detto ciò la risposta a questa domanda è, in termini generali, negativa. Lo è a dispetto di alcuni singoli percorsi personali con esito positivo. Tuttavia, i principi e gli obiettivi sanciti dalle norme vigenti non contemplano una selezione che permetta solo a una minoranza di detenuti di accedere a percorsi di recupero, lasciando il resto a scontare la pena in un regime puramente detentivo. Nessuno ha previsto percentuali massime di recupero o criteri per determinare la componente reclusa da privilegiare con proposte formative o lavorative.
Queste considerazioni trovano puntuale riscontro nei primi passaggi dell’Ordinamento penitenziario (legge 354/1975), secondo il quale «il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni […] si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione».
Lo dice la legge, non la garante: ogni persona ristretta mantiene i propri diritti, fra i quali certamente quelli contenuti nello stesso apparato normativo che ne disciplina l’esperienza reclusiva. Questo sul piano teorico, ideale. Su quello della pratica le cose stanno diversamente. Innanzitutto perché la scarsità di risorse, umane e materiali, fornite dagli organi centrali dello Stato, impedisce di sviluppare la benché minima ambizione di veder realizzato quanto disposto dalle norme.
Spazi malsani, obsoleti e comunque inadeguati, personale a sua volta inadeguato per quantità e spesso per qualità, logiche operative che denunciano un approccio nel quale prevale la visione della pena declinata esclusivamente in termini privativi, una sanità che non è in grado di garantire standard accettabili, desertificazione affettiva, un panpenalismo che non solo ignora il dramma del sovraffollamento, ma lo aggrava con interventi che generano nuova reclusione.
L’esperienza di questi ultimi dieci anni mi fa rispondere negativamente: no, la dignità e il recupero non sono affatto garantiti per tutti, anzi. Il fatto che questa condizione appartenga all’intero scenario nazionale delle privazioni della libertà anziché consolare, angoscia ulteriormente. Dove, in una cornice di vendetta istituzionale, non ci sono equità e coerenza, non può esserci dignità. Come ovviare a questo stato di cose? Invertendo completamente la rotta ma, applicando il principio di realtà, devo affermare che tale aspettativa non è storicamente collocabile nei prossimi anni».
Questa puntata di L’Unica Torino termina qui. Se ti è piaciuta, condividila! E se pensi che ci sia una storia di cui dovremmo occuparci, faccelo sapere: ci trovi a info@lunica.email.
Ti consigliamo anche:
🧠 L’intelligenza artificiale può contrastare la fuga dei cervelli (da L’Unica Alessandria)
👷🏼 Salvini ha rinviato ancora l’avvio dei cantieri del ponte sullo Stretto (da Pagella Politica)
🔠 Attorno alla parola “genocidio” c’è sempre stata molta conflittualità (da Facta)