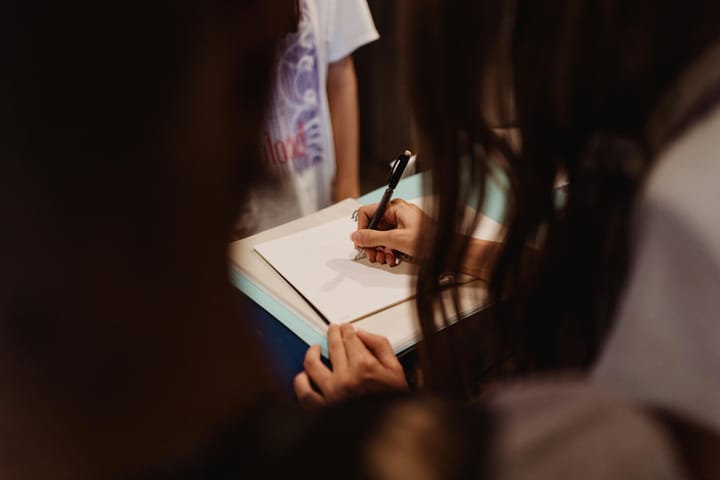Scrivere dal carcere diventa più difficile: il caso di Ivrea

L’Unica è una newsletter gratuita che ogni settimana ti manda via mail una storia dal tuo territorio.
Abbiamo altre quattro edizioni: Alessandria, Asti, Cuneo e Genova.
Per riceverla,
clicca qui
«A novembre 2024 ho provato a entrare in carcere ma all’improvviso l’ingresso mi è stato negato. Non sapevo cosa fosse successo: la mia autorizzazione era scaduta e nessuno mi aveva avvertita. Ho poi saputo che per la direzione gli articoli de La Fenice non avevano una funzione rieducativa. Erano tristi, non comunicavano speranza. E così qualcosa andava cambiato».
O.R.L. racconta a L’Unica la fine di un’esperienza che lei stessa aveva contribuito a far nascere. È stata tra le fondatrici della redazione interna de La Fenice presso la casa circondariale di Ivrea, nata nel 2018 e attiva fino alla fine del 2024. Sei anni di lavoro, incontri settimanali, articoli scritti dai detenuti, interrotti improvvisamente con una decisione che ha lasciato sgomento.
La Fenice
L’idea era semplice: costruire un giornale interno – un inserto online che potesse affiancare il periodico di Ivrea Varieventuali – dando voce a chi viveva la detenzione. «A ottobre 2018 è nato il primo gruppo di lavoro, cinque o sei persone», ha ricordato la redattrice. «Io e l’altro responsabile andavamo a fare riunioni ogni settimana. Gli argomenti erano vari: l’affettività, la quotidianità, i casi di cronaca. C’era chi scriveva riflessioni personali, chi raccontava episodi di vita, chi si lanciava in commenti sull’attualità. Non tutti avevano esperienza di scrittura, ma proprio questo era il bello: imparare insieme».
Il nome, La Fenice, non era stato scelto a caso. Simboleggiava la rinascita, la possibilità di risorgere dalle ceneri, di ricominciare. Molti vi riconoscevano il proprio desiderio di cambiamento: un riscatto che non passava per gesti clamorosi ma per la pazienza delle parole.
Nei primi anni la redazione è stata un punto di riferimento. «Si discuteva di tutto, in un clima di confronto libero ma rispettoso». Per i volontari che accompagnavano i detenuti, il progetto aveva un valore profondo. «Era un modo per dire che in carcere non si smette di pensare, non si smette di avere idee. Scrivere significava ritrovare un’identità, rimettere insieme i pezzi della propria vita, guardarsi allo specchio senza paura», ha detto ancora O.R.L.
Molti testi, riletti oggi, sono toccanti. Raccontano la distanza dagli affetti, le difficoltà delle relazioni familiari, la nostalgia per i figli lontani. Altri denunciano problemi concreti, come la carenza di spazi adeguati, le difficoltà di accesso alle cure mediche, le tensioni quotidiane. Alcuni esprimono gratitudine verso gli agenti di polizia penitenziaria, quando si erano fatti carico delle mancanze della struttura.
Il momento di rottura è arrivato dopo un episodio tragico. Andrea Pagani, uno dei detenuti più attivi nella redazione, è morto per un edema polmonare a gennaio 2024 dopo aver chiesto per giorni di essere ricoverato. I compagni hanno deciso di dedicargli un articolo, un testo in cui hanno unito dolore e critica verso l’istituzione: «Se il medico avesse perso dieci minuti in più del suo tempo col ragazzo che poi è deceduto – si legge nel testo, ancora disponibile online – magari ora non si starebbe nemmeno parlando di questo caso e si sarebbe salvata la vita a una persona di soli 47 anni». E ancora: «Quando sui tg parlano di rivolte in carcere, a volte sarebbe bene capire anche il vero motivo per cui i detenuti mettono in atto la massima espressione di protesta in carcere con una rivolta».
Da allora, raccontano i volontari, il clima si è fatto più teso. Gli articoli sono stati giudicati «non rieducativi», troppo cupi, incapaci di trasmettere un messaggio positivo ma piuttosto «un’immagine negativa» della vita dietro le sbarre. «È una contraddizione enorme», ha replicato O.R.L. «Da una parte si dice che bisogna garantire la libertà di pensiero, dall’altra si stabilisce che bisogna scrivere solo cose allegre. Ma il carcere non è un parco giochi: è fatto di sofferenza, di mancanza, di fragilità. E queste voci devono poter emergere».
Se questa newsletter ti è stata inoltrata, puoi iscriverti cliccando qui:
Il 24 gennaio 2025 è arrivata la comunicazione ufficiale, firmata dalla direttrice Alessia Aguglia. Nella lettera si legge che la partecipazione dei detenuti alla redazione del giornalino interno costituisce «un’ottima occasione non solo per garantire il diritto all’informazione ma anche per assicurare la tutela della libertà di pensiero». Tuttavia, si specifica, è necessario espletare alcuni approfondimenti sui computer utilizzati, modificare la convenzione che regge La Fenice («ritenendo che a garanzia della reale efficacia dell’attività in oggetto sia assolutamente necessario e imprescindibile una predeterminazione chiara dei parametri e dei criteri entro cui la stessa deve svolgersi») e individuare altri operatori come soggetti incaricati del progetto, poiché «si ritiene venuto meno il rapporto di fiducia» nei confronti dei redattori storici e «si comunica che gli stessi non potranno più accedere in istituto come volontari».
Parole che lasciano poco spazio a interpretazioni: La Fenice potrà forse continuare, ma non con chi l’ha fatta nascere. E infatti, nei mesi successivi, nonostante un ricco scambio di e-mail tra gli ex redattori e la direzione dell’istituto, l’attività si è fermata del tutto.
La direttrice – che pure nell’ultimo anno si è resa protagonista di alcune iniziative a favore dei detenuti, dalla giornata “Bambini dietro le sbarre” che ha permesso ai reclusi un pomeriggio di giochi con le famiglie al programma ”Gatti galeotti”, con l’adozione di sette felini da accudire nelle celle – dopo la lettera non ha mai commentato pubblicamente la sua decisione. Ma è probabile che l’articolo sulla morte di Pagani abbia provocato tensioni, tanto più che i medici del carcere coinvolti nella vicenda sono stati raggiunti da un avviso di garanzia per omicidio colposo.
Non è la prima volta che nel carcere di Ivrea la parola scritta diventa terreno di scontro. Dal 2000 esiste L’Alba, il giornale cartaceo curato dall’Associazione assistenti volontari Tino Beiletti. Per vent’anni L’Alba è stato stampato all’interno della casa circondariale. Dal 2020, per motivi organizzativi, la stampa è stata spostata all’esterno. È uno dei periodici carcerari più longevi in Italia, e ha dato voce a centinaia di persone detenute in oltre vent’anni.
«Ci troviamo due volte a settimana, siamo una quindicina. Discutiamo, ci confrontiamo, sempre con rispetto», ha spiegato a L’Unica Armando Michelizza, presidente dell’associazione. Negli ultimi mesi, però, anche L’Alba ha conosciuto una fase di transizione: tra la fine del 2024 e l’estate del 2025 le pubblicazioni hanno subìto un rallentamento, conseguenza delle nuove regole introdotte. Michelizza non ha nascosto le difficoltà: «Abbiamo accettato due condizioni che non ci piacciono: la possibilità per la direzione di leggere le bozze e l’anonimato obbligatorio dei pezzi. Lo abbiamo fatto per non perdere la possibilità di incontrarci. Ma è chiaro che così la libertà di parola è limitata».
Il tema dell’anonimato nei giornali carcerari è dibattuto. Sull’argomento si è espresso anche Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex ministro della Giustizia nel primo governo Prodi (1996-1998). «Se il carcere è il luogo della rieducazione non può essere il luogo dove si perde anche il diritto di pensare, di raccontare, di firmare il proprio nome», aveva detto Flick.
Ivrea, ma anche il resto d’Italia
Le vicende di Ivrea non sono isolate. In molti istituti italiani i giornali interni vivono difficoltà simili: autorizzazioni lente, controlli preventivi, limiti all’uso delle tecnologie, divieti di firma. A Lodi la direzione del carcere ha vietato ai detenuti di parlare di temi sensibili (come l’immigrazione) sul giornale Altre storie, i cui articoli venivamo ripresi dal quotidiano locale Il Cittadino. A Trento non è stato rinnovato il permesso di entrare in carcere al direttore del periodico Non solo dentro. A Rebibbia, per un certo periodo, i redattori di Non tutti sanno hanno dovuto chiedere alla direzione del carcere il permesso di firmare gli articoli.
A luglio 2025 il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato un ordine del giorno per «tutelare i giornali dove collaborano i detenuti». Qualche mese prima, in aprile, un documento sottoscritto da diverse redazioni carcerarie, e condiviso in seguito anche da L’Alba, è stato inviato al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con un appello chiaro: «Chiediamo rispetto della libertà di espressione, autorizzazione all’uso di tecnologie, tempi rapidi nelle risposte, adeguata considerazione dell’attività svolta dai volontari operatori della comunicazione».
Nel documento i firmatari hanno ricordato i principi normativi: «L’articolo 18 dell’Ordinamento penitenziario, dando concreta applicazione all’art. 21 della Costituzione, così recita al comma 8: “Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento”. Ma le cose non sono così semplici, e questo diritto delle persone detenute a esprimere le proprie opinioni è tutt’altro che rispettato». I firmatari, tra le altre cose, hanno chiesto come fosse «possibile effettuare il lavoro redazionale senza poter usare, almeno in presenza e sotto la responsabilità di operatori volontari, elementari strumenti tecnologici come registratore, macchina fotografica, connessione Internet?». Infine, hanno denunciato la lentezza amministrativa. «Articoli che parlano del caldo asfissiante nelle celle e vengono autorizzati alla pubblicazione a Natale, richieste di permessi di ingresso di ospiti significativi che arrivano a volte con lentezza esasperante, attese snervanti per introdurre materiali indispensabili per il nostro lavoro, sono tutte situazioni che oggettivamente finiscono per vanificare il lavoro delle nostre redazioni», si legge nell’appello. «Giornali, podcast, trasmissioni radio-TV, laboratori di scrittura sono una ricchezza culturale che va salvaguardata e facilitata: per questo chiediamo che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ci riceva e affronti con noi i temi che abbiamo sottoposto alla sua attenzione».
Un tavolo che ha visto anche la voce di Ivrea. «Siamo in contatto con le altre realtà italiane – ha spiegato Michelizza – e speriamo di riuscire a ottenere qualcosa. Firmare gli articoli, ad esempio, non è solo una questione di libertà di pensiero, ma può diventare anche un’opportunità di reinserimento, una volta fuori, per chi desidera intraprendere una carriera giornalistica».
Questa puntata di L’Unica Torino termina qui. Se ti è piaciuta, condividila! E se pensi che ci sia una storia di cui dovremmo occuparci, faccelo sapere: ci trovi a info@lunica.email.
Ti consigliamo anche:
🍇 Il ritorno dei giovani nei vigneti dell’Alessandrino (da L’Unica Alessandria)
👉🏽 Come nasce un partito di “estremo centro” (da Pagella Politica)
🏳️🌈 Iscriviti a Politica di un certo genere, la newsletter gratuita di Pagella Politica sulle questioni di genere